evento in collaborazione con Istituto Superiore “V. De Caprariis”, Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Studi Umanistici e Società Filosofica Italiana – sezione napoletana “G. Vico”
in presenza e online
martedì 30 settembre 2025 | ore 10.00
Aula magna | Istituto Superiore “V. De Caprariis”
via V. De Caprariis, 1 | Atripalda (AV)
Ingresso gratuito con prenotazione
COME IMPARO OGGI?
Breve viaggio tra formule linguistiche e figure dell’anima
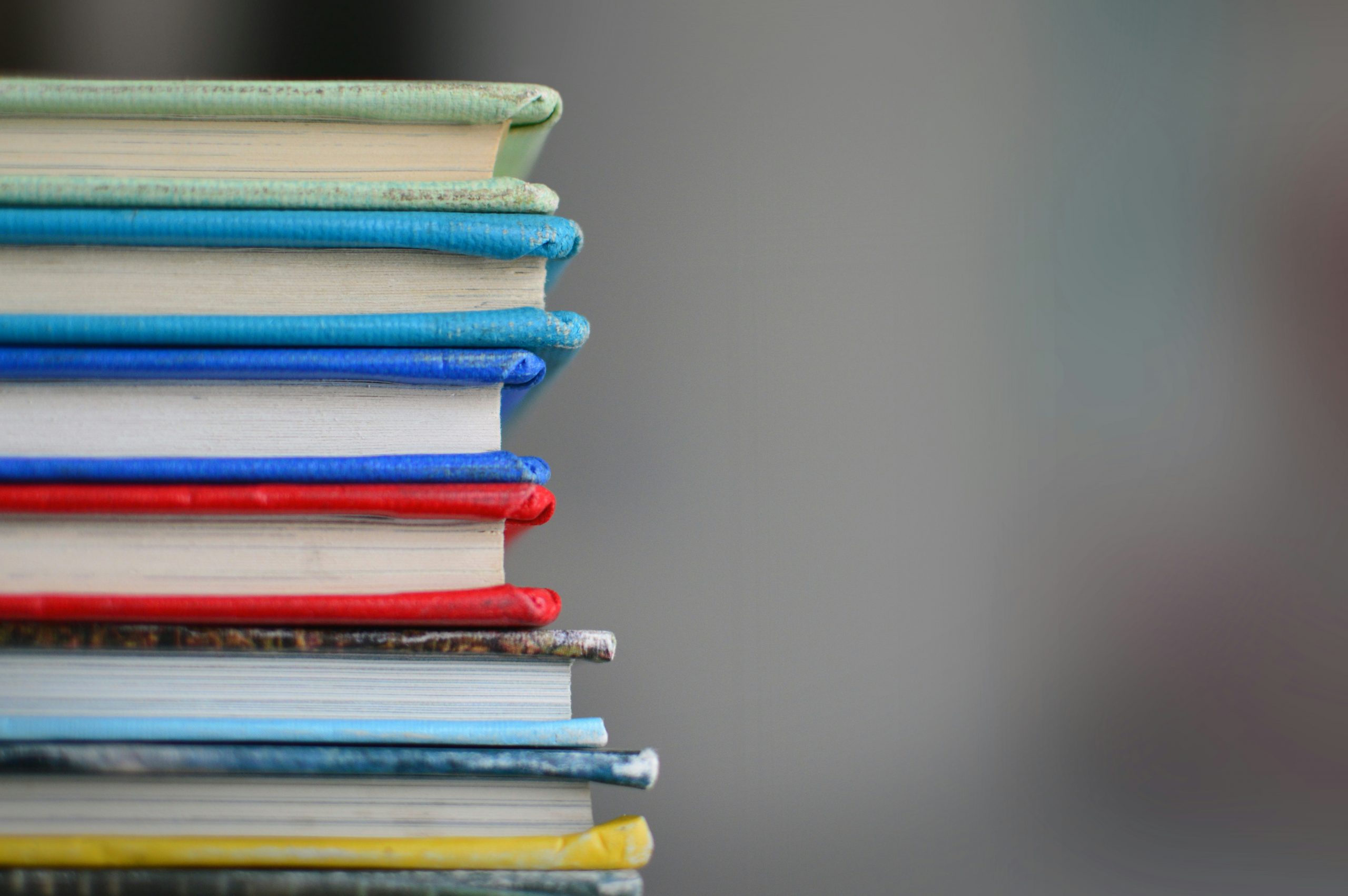
Come imparo oggi? Da cosa imparo oggi? In questo breve viaggio tra le parole degli antichi andremo alla scoperta di un particolare tipo di discorsi. Si tratta dei discorsi in cui le parole hanno lo stesso potere delle figure geometriche, quando dimostrano, e lo stesso potere delle immagini visive, quando convincono. Grammatica, retorica, matematica e filosofia si mettono a dialogare alla ricerca delle parole giuste da usare.
Si apprende più dalle spiegazioni o dagli esempi? E cosa significa apprendere? E una volta che avrò appreso come farò a ricordare, a trattenere nella mente la mia conoscenza? E cosa rende diverso il discorso appreso da ciascuno? Queste alcune delle domande a cui docenti universitari e giovani ricercatori proveranno a rispondere attraverso la voce degli antichi, convinti che insegnare e imparare siano come intrecciati in quel privilegio del dialogo tra maestro e allievo che è continua scoperta, non trasmissione di conoscenza ma ricerca condivisa e continua.
Saluti istituzionali:
ANTONIO SPAGNUOLO, Dirigente Scolastico Istituto Superiore “V. De Caprariis”
Introduce e modera:
PIERA DE PIANO, Istituto Superiore “V. De Caprariis”
Intervengono:
- S’impara più dagli esempi o dalle spiegazioni? Un dibattito che continua
GIGI SPINA, Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof, vuole che la ascolti come un ragazzo ascolta un vecchio che racconta o che prenda appunti della sua spiegazione? Protagora 4.0
Imparare e insegnare distinguono il ruolo di studenti e docenti nella scuola; mi chiedo se si possa imparare o insegnare senza averne chiaro il continuo intreccio. Il modello “docente che spiega, studente che prende appunti” si riversa nella interrogazione/verifica: “lo studente relaziona, il docente valuta”. Occorre recuperare la forza dell’esempio (paradeigma), che rende visibile l’intreccio.”
- Imparare. Si può?
ANGELO MERIANI, Università degli Studi di Salerno
Socrate, prima di incontrarti avevo sentito dire che tu non fai altro che sollevare difficoltà, in te e negli altri. Ora mi affascini e mi ammali, realmente mi incanti, al punto che sono pieno di dubbi.
In un famoso brano del Menone di Platone, Socrate mostra che anche uno schiavo ignorante può riuscire a risolvere un complesso problema di geometria: insegnare non consiste nell’impiantare conoscenze dall’esterno, ma nell’aiutare l’allievo a portare alla luce ciò che già, in qualche modo, sta dentro di lui. Il sapere non viene trasmesso, ma suscitato. Il vero insegnamento è una guida al risveglio interiore e alla ricerca autonoma della verità.
- Figure per apprendere e per ricordare nei dialoghi di Platone
LIDIA PALUMBO, Università degli Studi di Napoli Federico II
È difficile, mio caro amico, esporre in maniera soddisfacente qualcosa di importante senza servirsi di esempi. C’è il rischio, infatti, che ciascuno di noi sappia tutto come in un sogno e tutto, viceversa, ignori una volta sveglio. Platone, Politico
I dialoghi di Platone sono testi illustrati, sono cioè abitati da figure, ma si tratta di figure speciali, perché sono figure fatte di parole. Che significa figure fatte di parole? Significa che le immagini non sono nel testo, ma si creano nella mente dei lettori quando essi leggono il testo. Ecco la straordinaria caratteristica della scrittura di Platone, che è una scrittura visiva, fatta cioè di parole che fanno vedere. Allora noi possiamo chiederci: perché Platone usa questo tipo di scrittura, qual è la finalità della scrittura visiva? Nei dialoghi troviamo la risposta a questa domanda. Quando un testo è non solo un testo parlato e letto, ma offre anche un versante visivo al suo fruitore, allora quel testo è in grado di far apprendere a chi lo legge il messaggio che esso veicola.
- Seneca e il discorso come immagine dell’anima
CARLO DELLE DONNE, Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Oratio imago animi est – Il discorso è immagine dell’anima
Come si spiega il fatto che, anche a parità di educazione, ciascuno parli diversamente, a modo suo? Nella mia comunicazione, mi soffermerò sulla concezione che, del discorso, ha elaborato il filosofo romano Seneca. La chiave di tutto è la condizione in cui versa lo hegemonikòn, cioè la mente di chi parla. Il discorso, il linguaggio sono un’immagine dell’animo di chi parla e scrive. Come ha messo in luce la studiosa Margaret Graver, l’espressione verbale del pensiero è prodotto dell’organo stesso del pensiero, cioè dell’animo; per questo motivo, se una causa – in questo caso, lo hegemonikòn – verserà in condizioni negative, queste ultime si rifletteranno anche sui suoi prodotti: cioè sull’oratio. Per parlare bene, insomma, occorre che il proprio animo stia bene; e perché ciò avvenga, deve essere educato alla filosofia.
Partecipano:
le studentesse e gli studenti delle classi 4A e 5C del Liceo Scientifico di Atripalda e 4A del Liceo Scientifico di Solofra
