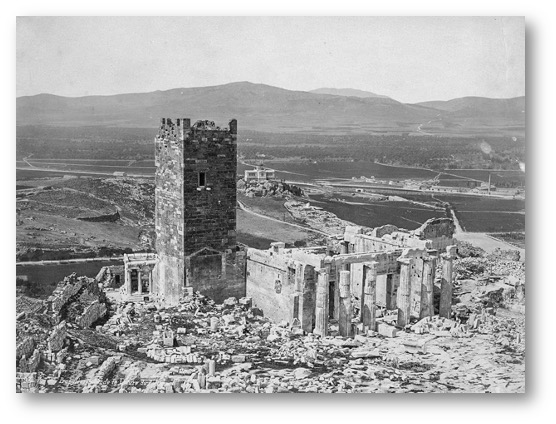ATENE: LA STORIA, IL MITO
Intervista a Giorgio Ieranò, Università degli Studi di Trento, e Donatella Puliga, Università degli Studi di Siena
Aprile 2023
Quattro studenti al terzo anno del Liceo Classico Massimo D’Azeglio di Torino, intervistano Giorgio Ieranò e Donatella Puliga, già all’interno delle attività di PCTO che il liceo svolge con il Club di Cultura Classica “Ezio Mancino” ONLUS. Il professor Ieranò e la professoressa Puliga saranno ospiti dell’Associazione mercoledì 19 aprile (ore 18.00) con l’incontro “ATENE: LA STORIA, IL MITO“, in presenza presso la Biblioteca Ginzburg di Torino e su piattaforma zoom.
Quali sono le differenze tra lo stereotipo comune dello splendore di Atene classica e l’aspetto con cui apparivano realmente le strade della città?
Giorgio Ieranò – Naturalmente Atene è stata una città splendida e i monumenti che ci sono rimasti lo testimoniano; per tutte le città antiche siamo, però, vittima – per così dire – di una deformazione prospettica: sulla base dei documenti che ci sono rimasti, ci immaginiamo che fossero tutte città monumentali, splendenti di marmi bianchi o colorati, com’erano all’epoca. In realtà, se fossimo andati ad Atene anche nel suo momento di maggiore splendore, cioè nel V secolo a.C., probabilmente avremmo trovato una città che era fatta perlopiù di case basse a due piani con il tetto di legno e i muri costruiti con mattoni o pietre impastate col fango, quindi molto semplici da bucare e trapanare: i ladri infatti, quelli che noi chiamiamo “i topi di appartamento”, ad Atene venivano chiamati proprio “buca-muri”.
Immaginatevi anche una città in cui le strade, spesso, non erano lastricate: erano dei vicoli stretti e fangosi, anche perché Atene era cresciuta senza un piano regolatore, senza una progettazione, come accadrà magari per altre città greche in epoca più tarda. Non c’era l’illuminazione pubblica per cui era pericoloso uscire di notte: si rischiava facilmente di essere aggrediti e derubati. Inoltre, l’igiene pubblica era molto scarsa.
Insomma una cosa è la magnificenza volutamente propagandistica degli edifici pubblici che Pericle fa costruire, altra cosa sicuramente era la realtà della vita quotidiana per la gente comune.
Dei numerosissimi miti che nascono intorno alla città di Atene, quale rappresenta meglio l’ideale di classicità?
Giorgio Ieranò – Il più famoso mito ateniese è la storia di un eroe locale che però va in trasferta, ovvero la storia del viaggio di Teseo: un giovane principe ateniese che, non ancora re, si reca a Creta per entrare nel labirinto dove ucciderà il Minotauro e dove si salverà grazie al famoso filo d’Arianna. È un mito molto antico e molto famoso in tutta la Grecia e presto viene descritto anche in chiave simbolica della potenza ateniese: Teseo prende il mare e umilia il grande re di Creta Minosse, finendo per rappresentare la potenza navale ateniese che si sostituisce alla vecchia talassocrazia dell’isola di Creta. Tra il VI e V secolo a.C., Teseo diventa l’eroe civico per eccellenza, una sorta di Romolo per gli Ateniesi: a lui viene attribuita la creazione della polis attica (cioè della comunità cittadina mediante una confederazione dei diversi villaggi che prima erano indipendenti, quello che i greci chiamavano “sinecismo”) e, in maniera irrealistica, l’invenzione del regime democratico.
È bene ricordare, però, che oltre a questo mito, ne esistevano tantissimi altri ateniesi indigeni: in primo luogo, numerose altre vicende che riguardavano la storia di Teseo proprio nei territori dell’Attica e nei suoi immediati dintorni; inoltre, c’erano tante altre storie, forse meno famose per noi, ma che erano notissime e molto importanti per Atene, come tutti i miti che riguardano l’avvento di una divinità fondamentale per i Greci e gli Ateniesi: il dio Dioniso. Un mito straordinario che lo ritrae è per esempio quello che racconta di quando, arrivato per la prima volta in Attica, Dioniso regala il vino e insegna a coltivare la vite al pastore Icario. Intorno a questa vicenda si dirama il racconto dell’amore provato da Dioniso verso la figlia del pastore, Erigone: un amore tragico che si conclude con l’impiccagione della ragazza, che gli Ateniesi avrebbero ricordato con una festa che si svolgeva ogni primavera, “la festa dell’altalena”.
Esiste dunque tutto un patrimonio di miti ateniesi che talvolta non sono conosciuti, ma che per i cittadini del tempo erano importantissimi per raccontare se stessi e per definire la propria identità culturale.
Quali potrebbero essere tre motivazioni che hanno reso Atene la città dominante del Mediterraneo?
Donatella Puliga – Una prima motivazione è sicuramente la posizione geografica strategica di Atene, situata all’interno del bacino del Mediterraneo e al centro della regione dell’Attica, distante pochissimi chilometri dal mare. Questa ubicazione così strategica ha consentito dunque alla città di sfruttare risorse preziose attigue: ad esempio le miniere d’argento del Laurion, una zona che dista una cinquantina di chilometri da Atene.
Una seconda motivazione è la capacità di Atene di gestire questa posizione geografica in vista di un’espansione all’interno del Mediterraneo. Atene è diventata un punto cardine del dominio marittimo, anche grazie alla vittoria sui Persiani, sfruttata in funzione di propaganda politica e quindi di autoaffermazione del proprio potere.
Un altro punto importante da considerare è la sistematica sottolineatura dell’autoctonia: Atene si afferma anche perché sa ribadire il senso di appartenenza che accomuna i suoi abitanti, nati tutti nella stessa terra. Anche i miti delle origini della città marcano il fatto che i primi re che hanno governato Atene, come Cecrope o Erittonio, erano esseri strettamente legati alla terra, perché nati da essa: la madre-terra era di fatto per gli Ateniesi la garanzia della loro appartenenza e si era cittadini, come ribadisce la legge sulla cittadinanza varata da Pericle nel 451 a.C., solo se nati ad Atene, e da entrambi genitori ateniesi. Inutile dire che potevano dirsi cittadini esclusivamente i maschi adulti. A lungo andare però, l’autoctonia diventerà un punto di debolezza per la politica ateniese: infatti, la disfatta che fa seguito alla guerra del Peloponneso sarà dovuta anche alla difficoltà, per altri Greci, di combattere – con gli stessi diritti e doveri – a sostegno di Atene. Il riconoscimento, ad esempio, della cittadinanza agli abitanti dell’isola di Samo, fu tardivo e quindi praticamente inutile.
Vorrei mettere, infine, in evidenza un altro elemento: la capacità che Atene ha avuto, sul piano della tenuta istituzionale, di tenere compatta e unita l’idea dell’istituzione familiare: essa è infatti una città fatta di padri e di madri che gravitano intorno a valori maschili.
In questo tipo di società, Atene esorta i cittadini e le loro donne e mogli a guardare all’istituzione familiare protetta dalla dea Atena, che campeggia al centro dello straordinario monumento che è il Partenone. Se seguiamo il programma iconografico delle metope e del fregio, vediamo che il messaggio è molto chiaro: si sottolinea l’importanza dell’istituzione familiare e il rispetto dei propri ruoli: il maschio fa la guerra, la donna si dedica alle attività della filatura e della tessitura e mette al mondo dei figli. Assistiamo quindi a un paradosso: da un lato Atena è una dea molto “maschile”, che per nascere non ha bisogno della madre, perché lei, secondo il mito, nasce dalla testa di Zeus. Quindi questa donna, che viene collocata come consigliera degli eroi più valorosi, ha una personalità in cui non sembrano trovare posto né la sottomissione né il pudore riverente, tratti tipicamente femminili, per il mondo antico. Atena, come gli uomini, non conosce la seduzione dello specchio, il suo specchio è quello del guerriero, cioè lo scudo di bronzo. Questo equilibrio tra potere e saggezza, è secondo me, una cifra importante della città di Atene: come Atena è capace di utilizzare la ragione, così anche la città è consapevole della propria capacità dell’uso della saggezza. Dov’è il paradosso? Atena è una vergine per eccellenza, ma è un nume tutelare di una polis in cui tutte le istituzioni sono maschili e che identifica nel matrimonio i suoi valori principali. Come mai allora proprio Atena e non per esempio Era, grande dea del matrimonio? Cosa ci fa una donna senza uomini a presiedere una società in cui si chiede alle donne di essere a fianco agli uomini in maniera procreativa, ma anche sottomessa? Evidentemente tutto quello che alla dea è possibile, cioè non essere sposata, non dedicarsi alle attività femminili, è appunto prerogativa di una dea, e questo conferma paradossalmente che la prerogativa delle donne mortali è esattamente opposta. Allora Atena non è tanto al di fuori del matrimonio, ma al di là dell’istituzione matrimoniale, perché lei, che è divina, è l’unica che non ha bisogno di nozze per entrare nella città. Tutte le altre hanno invece il dovere di legare la propria vita al matrimonio.
Questa potente sottolineatura dell’importanza dell’istituzione matrimoniale è un altro punto che, a mio parere, fa sì che il potere di Atene sia molto forte fino al momento dell’esito nefasto della guerra del Peloponneso. Anche in questo caso Atene potrà però comunque dire: “Sparta avrà vinto, ma noi abbiamo la paideia, la cultura, l’educazione, la filosofia”. Questo perché c’è sempre un senso di grandissima superiorità da parte di questa città.